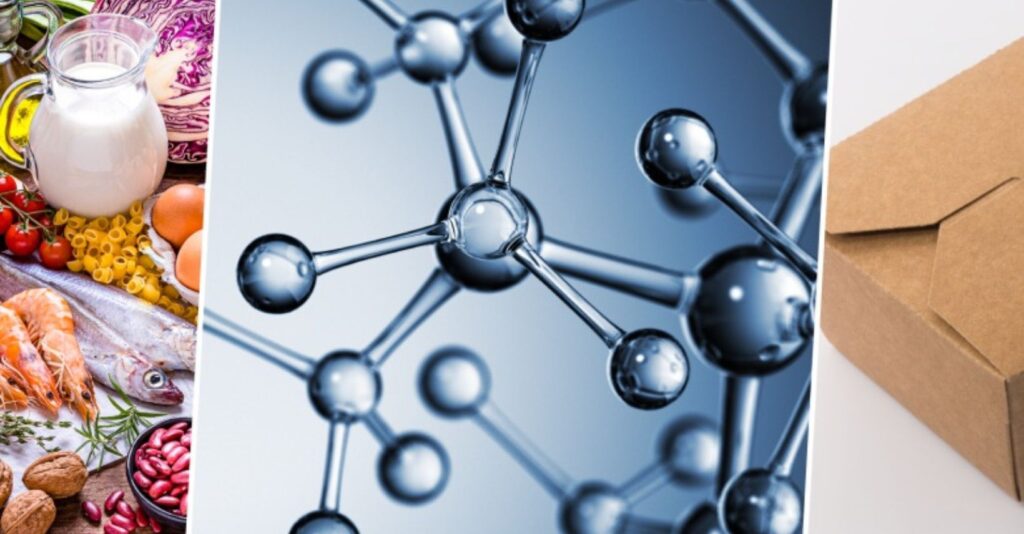Proprio mentre si parla di bioeconomia, agroecologia e circolarità, molte norme continuano a trattare l’agricoltura come un’industria chimica. E chi lavora con compost, digestati, biofertilizzanti si ritrova imbrigliato da ostacoli burocratici, mentre i prodotti di sintesi hanno percorsi autorizzativi più snelli e consolidati.
Eppure, il riutilizzo degli scarti agroindustriali rappresenta una delle leve più promettenti per rendere l’agricoltura più sostenibile, resiliente e competitiva. Compost, digestati, fertilizzanti organici e biostimolanti possono migliorare la salute del suolo, ridurre l’uso di chimica, trattenere carbonio e valorizzare risorse che oggi, troppo spesso, finiscono in discarica o diventano un problema ambientale.
Negli scarti organici agroindustriali si trovano moltissimi composti bioattivi che, se ben gestiti e valorizzati, possono avere effetti positivi su fertilità, struttura del suolo, microbioma e crescita delle piante. Sono già abbondantemente disponibili e senza troppi sforzi.
Molecole e composti funzionali utili per il suolo e le piante
1. Sostanze umiche (acidi umici e fulvici)
- Effetto: migliorano la struttura del suolo, la ritenzione idrica e stimolano l’attività microbica.
- Fonte: compost maturi, digestato ben stabilizzato, residui di colture erbacee.
2. Polisaccaridi (come la cellulosa, emicellulosa e pectine)
- Effetto: servono da fonte di carbonio per i microrganismi del suolo, favorendo la biodiversità microbica.
- Fonte: scarti della frutta, verdura, vinacce, bucce.
3. Lignina e fenoli naturali
- Effetto: migliorano la struttura del compost e hanno potenziali effetti antimicrobici/biostimolanti.
- Fonte: scarti della lavorazione del legno, potature, sansa d’oliva.
4. Peptidi e aminoacidi liberi
- Effetto: agiscono come biostimolanti e facilitano l’assorbimento di nutrienti.
- Fonte: residui della lavorazione animale (es. scarti di caseifici, industria ittica), digestati proteici.
5. Fitormoni naturali (auxine, gibberelline, citochinine)
- Effetto: regolano la crescita e lo sviluppo delle piante.
- Fonte: compost maturi, estratti da alghe e da alcuni sottoprodotti fermentati (es. scarti orticoli fermentati).
6. Chitina e chitinosani
- Effetto: stimolano la resistenza delle piante andando ad indurre la biosintesi dei metaboliti implicati nelle risposta difensiva ai patogeni.
- Fonte: scarti dell’industria della pesca (carapaci di crostacei).
I settori dove gli scarti diventano risorse in grado di salvare l’agricoltura
1. Industria ortofrutticola e conserviera
- Scarti: bucce, semi, polpe, acque di lavaggio.
- Utilizzo: produzione di compost ricco in polisaccaridi e sostanze umiche; anche digestione anaerobica per bioenergia + fertilizzanti organici.
- Beneficio: chiusura del ciclo locale e riduzione degli input chimici.
2. Industria vitivinicola
- Scarti: vinacce, raspi, fecce.
- Utilizzo: compostaggio o estrazione di polifenoli e tannini con effetto biostimolante e antiossidante.
- Beneficio: riduzione dei rifiuti e sviluppo di fertilizzanti naturali specifici per vigneti.
3. Industria olearia
- Scarti: sansa, acque di vegetazione.
- Utilizzo: compost, biochar o biostimolanti a base di fenoli naturali.
- Problema: alto carico organico, fitotossicità iniziale → serve trattamento adeguato.
4. Industria casearia
- Scarti: siero di latte.
- Utilizzo: produzione di digestato ad alto contenuto azotato o substrato per produzione microbica (biostimolanti, biofertilizzanti).
- Beneficio: azoto organico più disponibile rispetto a urea chimica.
5. Industria della pesca
- Scarti: teste, lische, carapaci.
- Utilizzo: estratti proteici, chitina e chitinosano, fertilizzanti organici liquidi.
- Beneficio: valorizzazione ad alto valore aggiunto, perfetti per colture ad alto valore.
Dalla chimica al biologico: il vero ostacolo alla sostenibilità non è tecnico …
Molti di questi scarti sono vere miniere di sostanze funzionali per il suolo e le piante. Oggi, non serve inventare nuovi concimi, ma saper leggere e valorizzare ciò che abbiamo già a disposizione. Per farlo, serve integrazione tra scienza, agricoltura e industria, con regole chiare e strumenti operativi semplici.
Eppure, nonostante i benefici siano ormai confermati da numerosi studi scientifici, le barriere normative e burocratiche continuano a rallentare l’adozione su larga scala di queste soluzioni. Definizioni poco chiare, autorizzazioni complesse e regole non armonizzate a livello europeo penalizzano soprattutto le piccole e medie imprese agricole.
Le lobby dell’agrofarmaco hanno ancora un peso enorme su questa transizione
1. Potere economico e influenza politica
I grandi gruppi agrochimici (le cosiddette “Big Ag”, come Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, Corteva, ecc.) muovono miliardi. Questo dà loro:
- accesso diretto ai decisori politici,
- potere di pressione nelle consultazioni normative (es. durante la revisione del Regolamento sui fertilizzanti, la PAC o il Green Deal),
- capacità di ritardare o modificare leggi che possono intaccare il loro mercato.
2. Controllo della narrativa scientifica
Finanziando studi, fondazioni, centri di ricerca e convegni, indirizzano il dibattito scientifico verso soluzioni “tecnologiche” (es. agrofarmaci di nuova generazione, OGM, precision farming con input chimici), lasciando in secondo piano l’agroecologia e le pratiche di economia circolare.
3. Lobbying nelle istituzioni europee
Nei corridoi di Bruxelles, secondo rapporti di organizzazioni indipendenti (come Corporate Europe Observatory), l’agroindustria è una dei settori più presenti ed influenti. E spesso riesce a:
- diluire obiettivi ambientali (come nel caso della proposta di ridurre del 50% l’uso dei pesticidi, ritirata nel 2024),
- ottenere deroghe o periodi transitori lunghissimi per l’eliminazione di sostanze chimiche.
4. Influenza sui finanziamenti pubblici
Anche i fondi della PAC (Politica Agricola Comune) vengono ancora in gran parte utilizzati per sostenere modelli agricoli intensivi, piuttosto che per premiare concretamente chi adotta pratiche rigenerative o circolari.
Oggi più che mai, serve un cambio di paradigma culturale oltre che tecnico
L’agricoltura circolare non è solo una questione di tecnologie o autorizzazioni: è una scelta di visione, di valori, di consapevolezza diffusa. Significa smettere di trattare il suolo come un substrato da correggere con input esterni e tornare a riconoscerlo come organismo vivente, da nutrire, rispettare e rigenerare.
Compost, digestati, biofertilizzanti non sono semplici alternative “verdi”, ma strumenti concreti per costruire un Agroalimentare al servizio della vita. E per farlo servono regole nuove, competenze condivise, filiere coese e menti libere.
📖 Di questo parla anche Nutrire il Bene, un libro-manifesto che esplora il potenziale del Sistema TRE-E (Emozioni, Etica, Energia), basato sulla Scienza della Felicità e il modello delle Organizzazioni Positive per trasformare le realtà agroalimentari in motori di rigenerazione.
👉 Solo coltivando il bene nella terra e nelle nostre scelte possiamo davvero nutrire il futuro.